Dov’è tutto? Niente di tutto quello che pensavo ci dovesse essere, c’era.
Alla fine del trionfale tour di The River, delle esplosioni di voci e luci degli stadi, Bruce Springsteen si scoprì vuoto. L’anestesia del successo e dell’energia collettiva non bastò più: dietro il clamore restava il silenzio spaventoso della depressione. In quel silenzio, il Boss incontrò uno spettro. Nel suo stesso riflesso, il fantasma dell’eredità familiare. Tutti, fuori, lo invocavano, come sempre. Ma lui non era pronto. È allora che sentì l’urgenza di fermarsi, di scavare. Di prendere tra le mani quel “qualcosa” che gli bruciava dentro e provare a trasformarlo – o lasciarlo distruggere tutto.
Così, tra il 1981 e il 1982, nella quiete sospesa di Colts Neck, nel New Jersey, si chiuse dentro quattro mura. Quelle settimane – che culminarono in una notte di registrazioni solitarie nella camera da letto e in una cassetta di demo che doveva suonare come una matura confessione – furono la genesi di Nebraska.
Oggi, Springsteen. Liberami dal nulla, il nuovo film di Scott Cooper con Jeremy Allen White, torna a quella notte: all’incontro di Bruce con il suo buio. Una confessione davanti allo specchio.
Le radici e l’ombra in «Nebraska»
Per rinascere, il Boss capì di doversi voltare: ripartire da sé, dalla sua identità, dalla sua provenienza. Farlo significava rientrare nella casa del suo «eroe e più grande nemico»: il padre Douglas. Un uomo attraversato dalle ombre e dal peso del disturbo bipolare, soggetto a scatti di rabbia che si abbattevano sulla famiglia.La depressione di Bruce era anche terrore. Aveva paura che quella stessa oscurità gli scorresse nel sangue, come una condanna ereditaria, come una maledizione scritta nel destino. Eppure, nella voce del padre, qualcosa di sacro continuava a risuonare.
Non riusciva a liberarsene, né ad accettare il modo in cui si erano separati. Continuava a bussare alla sua Father’s House, con un’intimità difficilmente eguagliata in altre canzoni. Il suo terapeuta gli avrebbe poi detto: «Tenti di rivivere ciò che è andato storto, pensando di poterlo rifare nel modo giusto, di poter rimediare. Ma non puoi farlo.»
She said “I’m sorry son but no one by that name lives here anymore»
My father’s house shines hard and bright
It stands like a beacon calling me in the night
Calling and calling so cold and alone
Shining ‘cross this dark highway where our sins lie unatoned
Nebraska non poteva che essere un’esplorazione nuda e profonda della propria disperazione, condotta con i soli mezzi essenziali. Una vocalità cruda, una chitarra, un’armonica. Un folk struggente, quasi privo di pelle, in cui si agitano emozioni impossibili da ignorare. È questo a renderlo diverso da tutto ciò che Bruce Springsteen aveva fatto prima. Nei dischi passati c’erano la fuga, la strada, l’orizzonte. L’America di Born to Run – animata da energia e ottimismo – correva via da una town full of losers (Thunder Road). Nebraska, invece, è la resa del ventenne che, divenuto trentenne, comprende che non si può scappare per sempre. Che prima o poi bisogna tornare: guardare in faccia le proprie radici, e accettare ciò che ci abita dentro.
«Nebraska»: ogni voce torna a sé
Nebraska was muddy, imperfect, unfinished. All the things that you shouldn’t put out, but he put out.
Dentro l’album si muovono figure spezzate: storie di solitudine, di uomini ai margini, di anime sospese sul confine tra il bene e il male. Occhi che rivelano omicidi, vite travolte da tempi difficili e da una muta disperazione. In Atlantic City, nella title track Nebraska, in Johnny 99, Highway Patrolman, State Trooper, i protagonisti uccidono senza un vero motivo, o restano imprigionati nelle proprie colpe. Sono persone comuni, spinte al limite: il terreno cede sotto i piedi, la bussola morale si sfasa.
They wanted to know why I did what I did
Well sir I guess there’s just a meanness in this world
Springsteen li osserva senza giudizio. Li racconta come se volesse salvarli, o salvarsi attraverso di loro. «I tried to locate where their humanity was, as best as I could», ha detto.
Quei pezzi furono per lui l’anticamera della terapia: una mappa dei futuri che temeva di vivere. Vedeva nei suoi personaggi versioni possibili di sé, abissi in cui sarebbe potuto cadere. Il Boss è dentro ognuna di quelle vite disperate e spaventate; in esse si nasconde, si moltiplica, si specchia.
Leggi anche:
Dylan, Carroll e il mistero dell’arte: perché non tutto deve avere senso?
Ma ci sono in Nebraska anche canzoni più intime, autobiografiche – Mansion on the Hill, Used Cars, la già citata My Father’s House – tutte viste attraverso lo sguardo di un bambino, come se Bruce riacquistasse quegli occhi curiosi che cercano di dare un senso alla realtà in cui sono nati. Non è un caso che si svolgano negli anni Cinquanta, il tempo della sua infanzia, e del suo trauma.
L’approdo del viaggio, il punto in cui ogni voce torna a sé. In Nebraska c’è tutto Bruce Springsteen. Un’eredità mai rinnegata. In un’intervista per il Sunday Morning di “CBS News”, ha confessato senza esitazioni: «Se dovessi scegliere un solo album per rappresentare gli ultimi cinquant’anni della mia vita, sceglierei Nebraska.». Con la disarmante semplicità di chi ha accettato le proprie imperfezioni: «Yes, I’ll take Nebraska.»
«La luna e i falò»: mettere radici
Proprio soglia degli anni Cinquanta, nel 1949, dall’altra parte dell’oceano – in quell’Italia che cercava faticosamente di rialzarsi dalle macerie – Cesare Pavese portò con sé, nella redazione dello Struzzo, un piccolo romanzo, il suo ultimo. Raccontava il rientro di Anguilla, emigrato in America, nelle Langhe piemontesi dov’è cresciuto, che ritrova segnate dalle ferite morali e materiali della guerra civile.
In Anguilla risuona costante il grande tema dell’escluso. Orfano senza radici certe, è un uomo mosso dal bisogno costante di conoscere sé stesso. È questo desiderio a spingerlo ad andarsene – e, soprattutto, a tornare. Perché la domanda che lo tormenta è precisa: un bastardo può avere una patria? E questa patria ha confini storici, una geografia, o è solo un punto smarrito nella coscienza?
La sua ricerca si svolge sul crinale sdrucciolevole tra ricordo e immaginazione. È un ritorno alla collina dell’infanzia, nella speranza che il paesaggio trattenga ancora qualcosa di ciò che ha perduto – o di ciò che non ha mai avuto.
Ho pensato sovente che razza di figli sarebbero potuti uscire da noi due. […] Venivamo tutti e due da chi sa dove, e l’unico modo per sapere chi fossimo, che cosa avessimo veramente nel sangue, era questo. Sarebbe bello, pensavo, se mio figlio somigliasse a mio padre, a mio nonno, e così mi vedessi davanti finalmente chi sono.
Già in America, nel desiderio di avere un figlio, Anguilla cerca un volto attraverso cui riconoscere finalmente il proprio ieri. Guardando quel bambino, spera di scorgere il padre, il nonno. Per l’orfano, il passato non si eredita: si immagina. Ecco allora che la collina dell’infanzia ritrovata diventa il solo terreno possibile su cui mettere radici. Un luogo fisico e simbolico insieme, dove la memoria si fa carne, e la nostalgia, storia. È lì che Anguilla prova a risolversi.
Leggi anche:
Cesare Pavese come poeta e traduttore
Nato dalla sua ultima penna, il protagonista di La luna e i falò è la voce stessa di Cesare Pavese. Dall’altra parte del foglio, c’era un altro bastardo, attraversato da una carenza identitaria profonda, da interrogativi senza risposta. L’essere orfano dell’autore, però, non si esauriva nella sua biografia: era esistenziale e culturale.
Pavese si sentiva fuori posto nel suo tempo. Durante l’occupazione, infatti, non fu partigiano, ma visse nascosto nel Monferrato, protetto dalla sorella. La colpa che gli pesò addosso non fu d’azione, ma di assenza. E quel vuoto divenne parte della sua identità. Anche per lui, la risposta al disagio fu un ritorno alla terra. Quella celebrata, quella ferita. L’ultimo appiglio possibile.
La scrittura che illumina e brucia
Tanto per Springsteen quanto per Pavese, la scrittura è stata una terra di padri (ri)trovati, di origini da reinventare, di dolori da chiamare per nome.
«La liberazione è sempre arrivata attraverso la scrittura», ha dichiarato il Boss. In Reason to believe, che chiude Nebraska, quella liberazione si fa suono.
Still at the end of every hard earned day people find some reason to believe.
Un sussurro. Un margine. Bruce, scrivendo a Colts Neck, attraversa la notte per scorgere, all’alba, un’idea di salvezza.
La luna e i falò, invece, non placa il disagio di Pavese: lo rivela ancor più chiaramente. Tra le pagine, i falò d’inizio estate non annunciano rinascite, ma divorano ogni cosa, non lasciando che cenere.
È dentro una casa che si è soli.
Scrivere, per entrambi, è stato un modo di tornare a casa, nell’isolamento fisico e mentale. Un ritorno che non segue superstrade né vicoli, ma scorre sotto pelle, e pulsa nelle vene. Da quella casa, però, escono con due creazioni diverse. Springsteen, con un disco che gli salva la vita. Pavese, consegnando al mondo un romanzo che lo spoglia di ogni illusione e lo accompagna fino all’orlo. La luna e i falò (acquista) è l’epifania del fallimento della ricerca di un posto nel mondo in cui essere al sicuro dalla violenza. L’inappartenenza, per Pavese, non è un passaggio: è un destino. È questa la consapevolezza con cui si chiude il suo libro. E, poco dopo, anche la sua vita.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!




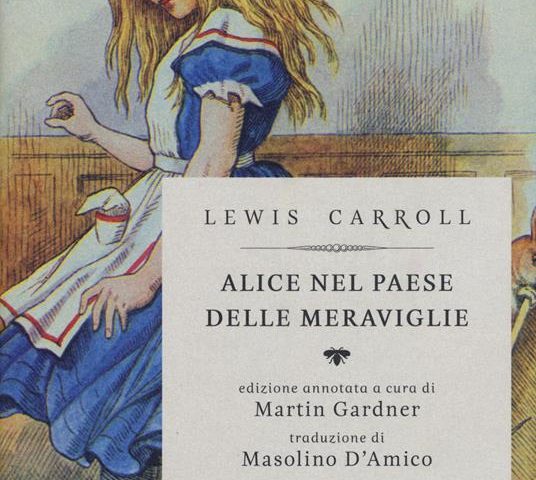


Riccardo un ragazzo bello bravo intelligente. Ti auguro che con lo studio la curiosità l amore per il bello libri, arte, valori della vita tutti i tuoi sogni si realizzino. Sentiamo sempre brutte notizie al telegiornale ma esistono anche questi bravi ragazzi futuro della nostra società.
Sono stata la maestra di Riccardo,sin da piccolo ha dimostrato di essere un bambino super sensibile e bramoso di apprendere!Bravissimo ,sono orgogliosa di te❤️
Riccardo è la prova che non tutto è perduto. Tenace e risoluto affronta tutti gli ostacoli pur di raggiungere il suo obbiettivo, e lo fa con il suo splendido sorriso perché è ciò che ama. La sua arma segreta è la curiosità per tutto ciò che è il sapere, e la curiosità, si sa, è fondamentale per chi non si accontenta solo di arrivare al traguardo ma lo vuole raggiungere “a pieno titolo”.