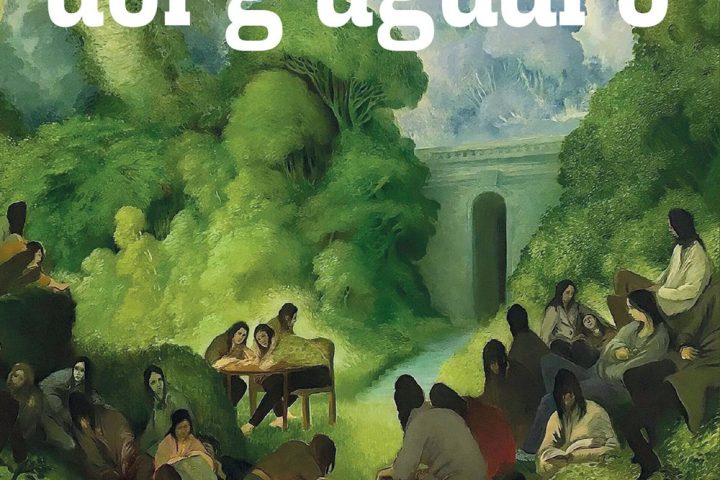L’epoca che stiamo attraversando è segnata da una serie di profonde fratture sociali sotto gli occhi di tutti: le guerre; le tensioni politiche e la crisi climatica. Seppur non sia in discussione la gravità della crisi sociale scatenata dalle guerre – poiché è una grave sconfitta dell’umanità – il cambiamento climatico imperversa non più in maniera naturale come dovrebbe essere. Infatti, l’eccessiva attività umana è la principale causa di determinati mutamenti che mettono seriamente a rischio le nostre condizioni di vita sul pianeta Terra.
A risentire di questi cambiamenti non è soltanto l’uomo, ma anche tutto ciò che riguarda l’ambiente in cui viviamo e la nostra percezione di esso, poiché viviamo ritmi frenetici e le nostre abitudini non sono più in armonia con il mondo. Nonostante sia difficile trovare una soluzione concreta, il saggio di Dario Giardi E se fosse la musica a salvarci? invita i lettori a riconsiderare il loro rapporto con la natura e con l’ambiente in cui vivono, a partire da una serie di riflessioni sul ruolo della musica nella nostra cultura e, dunque, nella nostra vita.
Il sottotitolo del libro, La memoria dei suoni e la sfida climatica, parte infatti dal concetto che determinati suoni evocano dei ricordi e delle abitudini culturali che, se recuperate oggi, darebbero un utile contributo a salvaguardare la biodiversità del pianeta.
L’armonia sonora della natura per riconnetterci
Se vogliamo una transizione ecologica reale, dobbiamo coltivare una “coscienza verde” capace di attraversare ogni barriera sociale, culturale, generazionale. Questa sensibilità deve nascere dall’esperienza quotidiana, dal recupero del senso dell’ascolto, dalla riscoperta di quei suoni autentici che definiscono comunità e appartenenza.
La tesi di fondo contenuta in E se fosse la musica salvarci? è un concetto semplice quanto incisivo: la lotta al cambiamento climatico deve necessariamente considerare il valore del paesaggio sonoro originario. Sfuggendo da retoriche ridondanti, l’autore propone in maniera ben articolata e lineare una serie di riflessioni sul ruolo dell’ascolto, capacità che nella sua opinione si è persa nel corso del tempo e che ha sempre unito i popoli del mondo. Infatti, alla base della forza propulsiva della musica vi è l’empatia, che unisce gli esseri umani non solo simbolicamente, ma soprattutto biologicamente.
Seguendo questo discorso, l’autore sostiene che l’atto musicale è sempre stato un rituale collettivo che univa tutte le specie viventi, specialmente l’uomo, con la natura, affinché funzionasse come strumento di conoscenza e comprensione del mondo. Se da una parte può sembrare scontato, dall’altra Giardi riporta come certi artisti – in una definizione che abbraccia anche coloro che praticano le arti visive – e compositori contemporanei effettuino pratiche di field recording, le quali prevedono la registrazione di suoni naturali per evocare dei paesaggi sonori che invitano gli ascoltatori a riconnettersi con l’ambiente, in armonia.
In un mondo sempre più dominato dal rumore artificiale, la musica che recupera i suoni della natura diventa un antidoto al disorientamento sonoro che spesso accompagna la vita urbana. Questi paesaggi sonori naturali non solo ci ricordano la bellezza del mondo naturale, ma ci chiamano a una maggiore consapevolezza ecologica e a un impegno diretto nella conservazione dell’ambiente.
Leggi anche:
Un’isola apparentemente tranquilla
Paesaggio sonoro e memoryscape
È dal paesaggio sonoro che l’autore invita a riconsiderare la nostra relazione con l’ambiente. Secondo la teoria – citata nel saggio – del musicologo R. Murray Schafer, il paesaggio sonoro è dato dall’insieme di suoni naturali che, proprio come un paesaggio visivo, orientano la percezione dell’individuo in relazione con il proprio benessere e con il mondo. Il recupero del paesaggio sonoro è l’inizio per sviluppare una nuova educazione ecologica, poiché secondo Giardi potrebbe essere fondamentale per ritrovare il senso stesso dell’umanità. Affinché ciò avvenga, bisogna tornare indietro per proiettarci nel futuro. È qui che l’autore introduce il concetto di memoryscape.
C’è una dimensione profonda e spesso trascurata del nostro rapporto con il mondo che ci circonda, una dimensione che risiede non tanto nelle forme visibili quanto nelle vibrazioni che ci avvolgono, nei suoni che permeano la nostra esistenza. È il suono del passato, una sinfonia invisibile che si intreccia con la trama della nostra storia, con il tessuto del nostro vissuto e con i luoghi che hanno fatto da sfondo alle nostre esperienze. Questo concetto, affascinante e ricco di significati, è il memoryscape.
Il memoryscape è un flusso dentro il quale si conservano tutti i ricordi di un individuo che siano generati da una sensazione, in questo caso sonora. L’autore propone il seguente esempio per chiarire il concetto.
Immaginate un villaggio di campagna, dove per generazioni il suono delle campane della chiesa ha scandito il ritmo della vita quotidiana, o un mercato brulicante di voci e richiami, che ora esiste solo nei racconti degli anziani. Pensate al suono del mare, che in un piccolo porto di pescatori ha accompagnato partenze e ritorni, gioie e tragedie, legandosi indissolubilmente alla vita della comunità.
I luoghi che viviamo e attraversiamo quotidianamente sono distaccati dalla natura e ciò provoca nell’uomo delle difficoltà psicofisiche apparentemente impercettibili che – anche se siamo abituati a non dare la colpa del tutto al clima – influenzano negativamente le nostre condizioni di vita. Dunque, se ogni suono può svolgere una funzione terapeutica importante, il memoryscape è un patrimonio da preservare, poiché da esso possiamo attingere per cambiare le nostre abitudini e instaurare una nuova coscienza ecologica sia sul piano personale, sia su quello collettivo.
Se da un lato ogni individuo custodisce la propria memoria sonora, dall’altro quella memoria si intreccia con quella di chi ci ha preceduti e con quella delle comunità che ci circondano. In questo modo, il suono diventa un veicolo potente di connessione tra il passato e il presente, tra ciò che eravamo e ciò che siamo.
Proteggere il nostro mondo con la musica
E se fosse la musica a salvarci? (acquista) è un saggio scritto con lucidità e con la determinazione di chi, pur non dichiarandosi un esperto, avanza una proposta solida sulla quale occorre riflettere parecchio. Naturalmente si tratta di un piccolo sforzo, ma se non si parte dal basso sarà sempre più difficile superare determinate difficoltà, causate spesso da certi stereotipi culturali che ci impediscono di andare oltre e di avere piena consapevolezza del problema.
Ritornare a dare valore all’ascolto non riguarda esclusivamente la musica, ma si tratta di una pratica umana profonda. Solo attraverso l’ascolto consapevole e condiviso potremo ritrovare quella connessione con l’ambiente che ci circonda, poiché così possiamo riconoscere e proteggere non solo la natura, ma anche noi stessi.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!