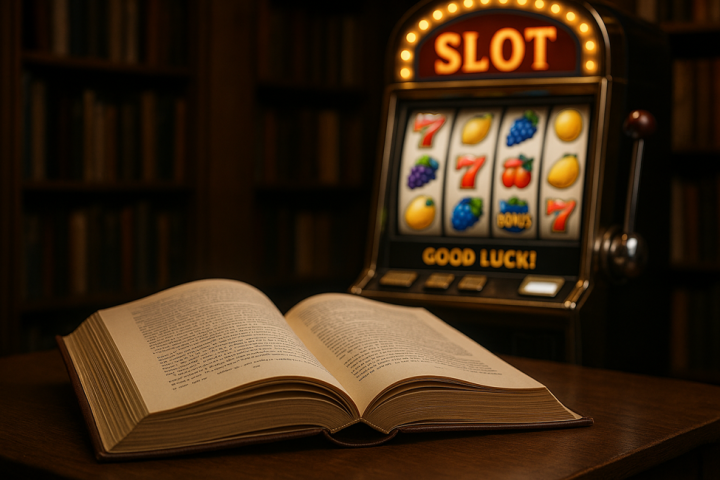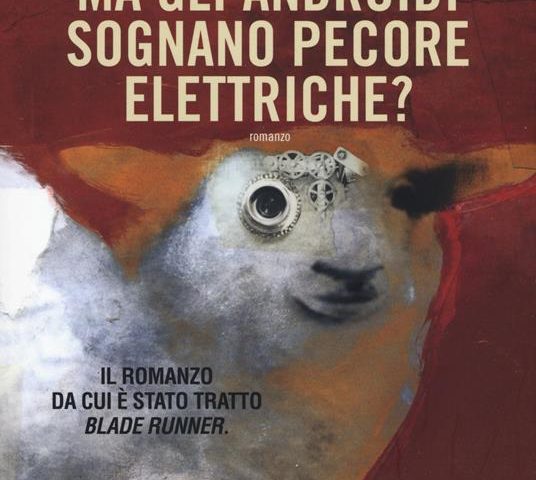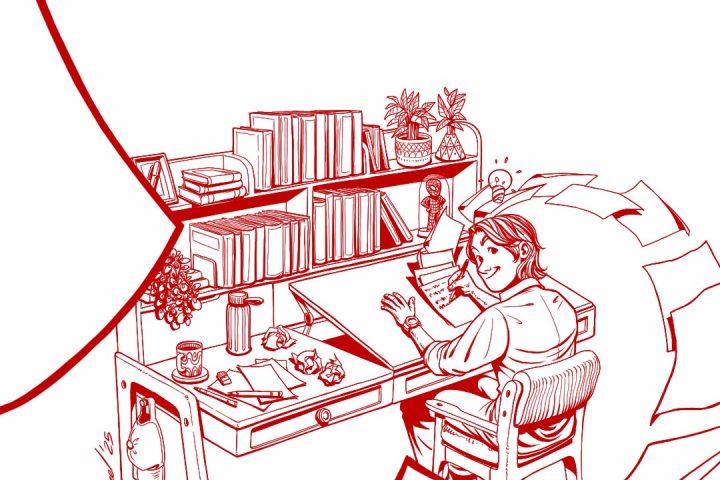Uno dei maestri della fantascienza, Jules Verne, scrive Parigi nel ventesimo secolo nel 1860, considerato allora troppo cupo (“non all’altezza” secondo alcuni critici) e per questo pubblicato postumo solo nel 1994. Fantasia e scienza: che cosa ci si può aspettare se non il racconto dell’evoluzione di società, utopiche o distopiche che siano?
Un’idea di fondo accomuna spesso questo particolare tipo di narrazioni: la rappresentazione della scienza e della tecnologia, viste come fredde e disumanizzanti. Uno degli effetti di questo tecno-capitalismo è lo sviluppo di una vita basata su interessi economici però apatica. Oggi è quasi banale indicare una perdita di alcune componenti morali, etiche e umane in favore di logiche capitalistico-tecnologiche fredde ma “utili”. Il subdolo meccanismo di attiva ma inconsapevole adesione a questo modello si basa sulla standardizzazione e sull’illusione di libertà e controllo.
Lo scopo sembra essere quello di eliminare le unicità per arrivare a uno standard di vita, mostrato come il migliore possibile. Pasolini, in un cortometraggio della RAI intitolato Pasolini e la forma della città (1974), riflette sul fascismo e sulla civiltà dei consumi, specie per quanto riguarda la repressione dell’individualità e l’acculturazione, come lui stesso la definisce. Lo scrittore racconta il fallimento del regime totalitario e il successo del consumismo nel cancellare le varie “realtà particolari”. Tale meccanismo viene portato avanti non tramite la criminalità, ma sostanzialmente non sviluppando le coscienze.
Gli autori di fantascienza riprendono ed estremizzano questi concetti, inserendo però alcune peculiarità specifiche (come religione e letteratura) che permettono ai personaggi di realizzare il proprio io e mantenere un lato umano – qualunque cosa significhi.
Leggi anche:
Leggere «Il Mondo Nuovo» dal nuovo mondo
Domande insolubili: cos’è umano?
Quali siano queste caratteristiche umane che la fantascienza tenderebbe a recuperare e che cosa significhi mantenere un’umanità di fondo è difficile da dire. Di volta in volta sono state oggetto di studio alcune possibili singolarità rispetto alle altre creature: dall’empatia, proposta da Philip Dick (e poi rimessa in discussione nel suo romanzo Ma gli androidi sognano pecore elettriche?), al linguaggio e allo sviluppo del cervello, fino all’organizzarsi in società complesse.
La possibilità di comunicare in modo articolato, derivante dal connubio tra una latente possibilità innata e alcune capacità tecnologiche e scientifiche evolute e migliorate da intuizioni più “semplici”, sembra una delle idee più quotate dagli studiosi. L’uomo non avrebbe così più trascorso la maggior parte del tempo nella soddisfazione dei bisogni primari. Il risultato fornirebbe tutt’ora la possibilità di formulare pensieri complessi, modi di comunicare e di razionalizzare il mondo.
Ampliare il paradosso
Se tutto questo dovrebbe quindi, da una parte, condurre a una pronunciata unicità di pensiero e di comportamento, dall’altro la civiltà, come abbiamo sottolineato all’inizio, tende a uniformare tali caratteristiche, sulla base della promessa di giungere a un certo modello di vita. In questo senso si è usato prima il termine “disumanizzazione” quando abbiamo parlato della rappresentazione di scienza e tecnologia.
Questo paradosso viene ampliato e, in genere, portato alle estreme conseguenze nella fantascienza tramite un ampio uso di simboli e credenze condivise che, discostandosi dal comune sentire, possono portare a nuove chiavi di lettura. Questa particolare intertestualità è probabilmente uno dei segreti del successo della fantascienza; si tratta della tipologia simbolica, ben nota nella tradizione filosofica e teologica classica, che forma una sensibilità e una consapevolezza risultando la scappatoia necessaria, come dicevamo, per mantenere un’umanità di fondo.
La letteratura può quindi ridestare l’individuo dal torpore distopico e renderlo unico. In Fahrenheit 451, ispirato dai celebri roghi di libri, Ray Bradbury racconta un mondo distopico dove, per il mantenimento del potere e per la sottomissione popolare, i pompieri bruciano i libri. Questa pratica non permette alle persone di poter sviluppare le proprie idee, una coscienza e una cultura. In modo significativo, Heinrich Heine scrisse: «Là dove si danno alle fiamme i libri, si finisce per bruciare anche gli uomini».
Leggi anche:
«Storia vera» di Luciano: proto-fantascienza?
«Parigi nel ventesimo secolo»: il futuro secondo Jules Verne
In Parigi nel ventesimo secolo (acquista) gli umanisti e gli studi classici vengono osteggiati: la società è infatti concentrata su produzione e guadagno. Il protagonista e un suo zio vengono visti come deviati, in quanto appassionati di letteratura francese classica. Leggendo l’opera, le discussioni tra i due personaggi e quelle con altri artisti, incentrate principalmente su questioni ultime o comunque tanto care ai libri, come amore, morte e guerra sembrano dare colore al mondo, per il resto fortemente grigio e piatto. In una Parigi proiettata nel futuro, ci viene mostrato come questi discorsi siano ritenuti assolutamente inutili dalla massa e dai familiari stessi del protagonista. Lo zio tutore del protagonista, rispettabile a differenza del fratello bibliotecario, viene così descritto:
Stanislas Boutardin era il prodotto naturale di quel secolo industriale; era cresciuto in una serra riscaldata anziché svilupparsi in mezzo alla natura; uomo soprattutto pratico, non faceva niente che non fosse utile, dirigendo le sue minime idee verso l’utilità, con un desiderio smodato di essere utile che derivava da un egoismo decisamente ideale, unendo l’utile allo sgradevole, come avrebbe detto Orazio; la vanità in lui affiorava riversandosi nelle sue parole, e ancor più nei suoi gesti, e lui non avrebbe mai permesso neppure alla sua ombra di precederlo; si esprimeva per grammi e centimetri. […] Disprezzava con atteggiamento regale le arti, e soprattutto gli artisti.
Gli artisti celebrano le meraviglie dell’industria e questo tipo di forma d’arte sarebbe dominante proprio perché “necessaria” per proporsi nel mercato del lavoro. Sarebbe facile vedere rispecchiate alcune correnti ideologiche di oggi che vorrebbero ridurre determinati insegnamenti nelle scuole, come il latino, visti come inutili per i giovani. Marc Augé, nel suo saggio Che fine ha fatto il futuro?, dà una conferma a questa radicale prospettiva pensata da Verne sulla costruzione dell’io e dell’individualità:
La letteratura, come ricerca o scoperta di sé e degli altri, possiede, per il solo fatto di questa dimensione, una forza critica e prospettica che travalica il proprio oggetto immediato. Non si può parlare negli stessi termini della città dopo Baudelaire o Dos Passos, della solitudine dopo Flaubert o Joyce.
Ri-svegliati, dormiente
«Dov’era quell’uomo? Dov’è qualsiasi persona quando una completa insensibilità si impadronisce di lei?». Questo è Graham, il dormiente nel romanzo Londra 2100 di H.G. Wells, che si scopre proprietario di gran parte del mondo dopo uno stato vegetativo di duecento anni, costretto a vivere e comprendere un mondo (perfino un sistema numerico) profondamente mutato nell’aspetto quanto nella morale.
Leggi anche:
Invasori da Marte
I personaggi dei romanzi sembrano riuscire a riattivare grazie (ad esempio) alla religione ed alla letteratura qualche cosa di individuale, indipendentemente dalle proprie peculiarità, diventando così unici. Se riusciamo a percepirli come attori positivi è proprio per questo loro distacco dalla realtà narrativa, come accade con il risveglio da uno stato ipnotico. La fantascienza ci indica allora, forse inaspettatamente per i non appassionati, alcune forme di difesa da questa pessimistica visione del tempo vissuto, passato, presente o futuro che esso sia.
Alberto Palmieri
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!