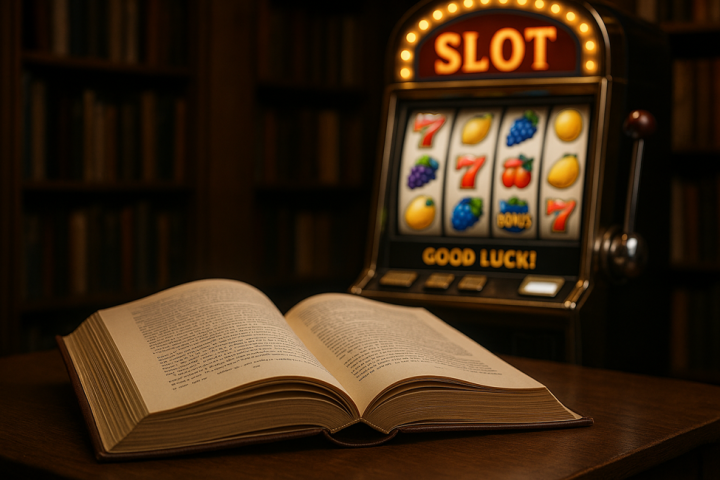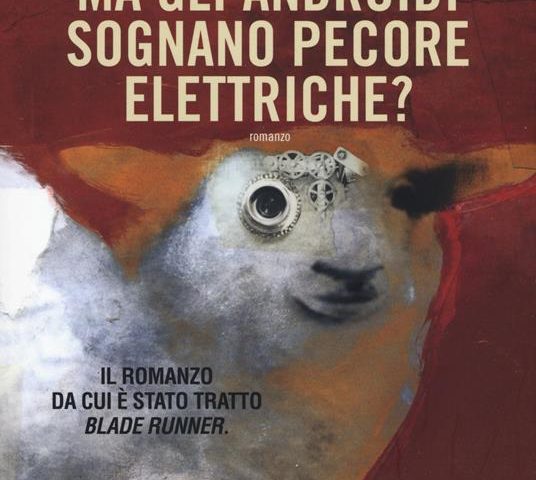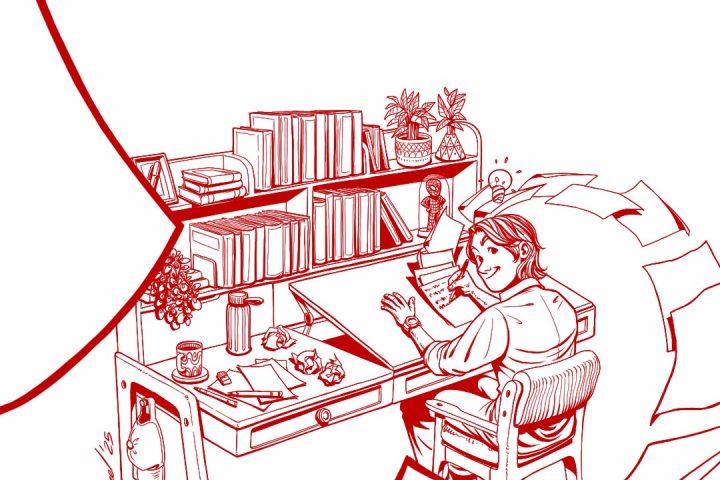Classicamente, gli studiosi indicano per la nascita della fantascienza una data e un contesto precisi. Un’anomalia, viste le generali difficoltà d’indagine quando si analizzano fonti e opere differenti. Racchiudere qualcosa all’interno di macro-insiemi definiti, delimitati da regole e stili, crea logicamente delle complessità, per l’eterogeneità, per le distanze temporali o per l’ambigua collocazione.
Difficile, non impossibile; è infatti ancor più sbalorditivo sapere che abbiamo un capostipite pressoché certo, ma non una definizione univoca del macro-insieme di studio. In sostanza sappiamo quando è nata la fantascienza ma non sappiamo definirla in modo rigoroso. Vuoi per capricci degli accademici, alle volte puntigliosi agli eccessi, vuoi per difficoltà oggettive di natura epistemologica, vuoi per una tardiva comprensione critica e, di conseguenza, metodologica del genere. Ancora oggi molti guardano alla fantascienza come un genere di serie B, sebbene le cose stiano radicalmente cambiando. Ma questa è un’altra storia.
La nascita della fantascienza moderna
Con Frankenstein di Mary Shelley, possiamo parlare di fantascienza. Per la prima volta un romanzo, prendendo spunto da esperimenti scientifici, conteneva una storia in grado di unire fantasia e scienza in modo convincente. Uno dei tratti senz’altro riconoscibili è proprio questo: un legame tra fantasia e scienza/tecnologia. Di per sé, la scienza non deve essere per forza coerente o realistica: alle volte è un semplice spunto per raccontare delle avventure altrimenti impossibili, altre viene usata sistematicamente per dare una coerenza con il mondo fisico, come nel caso di Jules Verne. Una non è necessariamente migliore dell’altra: quel che conta è la qualità narrativa. D’altronde, gli scrittori non sono necessariamente uomini di scienza.
Mary Shelley prese spunto dagli esperimenti condotti da Luigi Galvani alla fine del Settecento. Lo scienziato ipotizzò lo stretto rapporto tra elettricità e vita. Utilizzando come cavie delle rane confermò, come già avevano dimostrato altri, la contrazione dei muscoli collegati a un nervo grazie a uno stimolo elettrico. Queste connessioni elettriche tra cervello, nervi e muscoli, sembravano davvero essere la chiave per animare l’inanimato.
Leggi anche:
Dissezionando Mary Shelley
In più canonizzava all’interno della trama, e questo è il secondo elemento necessario, molti aspetti oggi attribuibili alla fantascienza, come uno sguardo etico nei confronti della scienza e un’aspra critica sociale. L’ideale di bellezza, la paura del diverso, le ambizioni personali che possono diventare ossessioni e condanne, sono solo alcuni dei temi presenti.
Ho così cercato di rimanere fedele alla verità dei principi fondamentali della natura umana, anche se non mi sono fatta scrupolo di innovarne le possibili combinazioni.
Mary Shelley, dalla prefazione di «Frankenstein»
Ritorno ai classici
Da queste semplici peculiarità si è poi sviluppata una delle tipologie narrative più interessanti degli ultimi due secoli. C’è però chi, avvalendosi delle difficoltà terminologiche, attribuisce alla fantascienza antenati antichissimi, classici senza tempo come L’Orlando furioso di Ludovico Ariosto o Utopia di Thomas Moore. Questi accostamenti però sembrano non reggere: sono più fantasy che fantascienza. Allora perché proporli come proto-fantascienza?
Cercheremo di trovare la risposta tramite una delle opere più interessanti nel novero dei possibili antenati: Storia vera di Luciano di Samosata.
Inventare una storia vera
Opera in greco antico databile tra il 150 e il 190 d.C., favolistico-parodistica, è uno scherno nei confronti degli storici, rei di inventare e diffondere avvenimenti falsi, e delle opere di avventura, poco coraggiose rispetto al loro potenziale. Fin dal titolo dimostra il suo carattere sopra le righe; nella Storia vera non c’è nulla di vero, se non l’ammissione della menzogna: «Non avevo nulla di vero da raccontare – giacché nulla di interessante mi era accaduto -, mi sono volto anch’io alla menzogna, ma un tipo di menzogna molto più onesto che quello degli altri. Giacché almeno in questo solo sarò veritiero, dicendo che mento».
Luciano narra un viaggio (come tanti nell’epica greca) verso le Colonne d’Ercole, piuttosto fortunoso per le condizioni climatiche avverse. Il protagonista, insieme a cinquanta compagni, partirà guidato da un’inesauribile sete di conoscenza e con l’obiettivo di esplorare l’ignoto. A causa di una tempesta si ritroveranno però in alcuni luoghi improbabili, tra questi il celebre approdo sulla Luna, dove abitano alcune creature strane e fantastiche.
Leggi anche:
Invasori da Marte
Sfatare un mito
Il viaggio sulla Luna: tanto è bastato ad alcuni per assegnare all’opera il carattere di proto-fantascienza. Certo, si tratta di un punto importante per quanto riguarda il racconto fantastico, il cosmo e la fantasia umana. Ma la questione spinosa è la seguente: le avventure spaziali sono fantascienza? O, meglio può trattarsi di una condizione singola e sufficiente?
La risposta è no, perché è evidente la mancanza di riferimenti scientifici (in senso lato); sono invece presenti eventi mitici e fantastici che permettono questo tipo di volo: quindi l’importanza del tipo di mezzo utilizzato. Inoltre, secondo talune interpretazioni, il viaggio spaziale in sé, più che una condizione, è solamente un possibile indicatore. Dato che spesso le vicende narrate in mondi fantascientifici includono questa possibilità, il collegamento è possibile. Tuttavia non si tratta di una proprietà fondamentale, perché la struttura narrativa manca di quell’idea nuova e distintiva, la “dislocazione”.
Leggi anche:
Scrittura di frontiera
Di cosa parliamo quando parliamo di fantascienza
Sfruttiamo qui l’interpretazione che diede Philip Dick, in una lettera inviata a Sebastiano Fusco, pubblicata (la sola nella loro corrispondenza) e analizzata sulla rivista Dimensione Cosmica. Dick è lapidario: la fantascienza non è riducibile a narrazioni nel futuro, in quanto ci sono storie ambientate nel passato e nel presente perfettamente ascrivibili al genere. Per avere una narrazione di fantascienza è necessario considerare una società fondata su quella reale, discostandosene via via (in modo più o meno profondo, questo dipenderà dall’autore): questa è la “dislocazione”. Ci si distanzia dal mondo fenomenico per almeno un aspetto, creando un qualcosa di nuovo e inaspettato (ma ben basato sulla quotidianità). Creando un distacco temporale ortogonale rispetto al reale.
Sebbene non si debba esagerare la portata di queste affermazioni, anche se arrivano da uno dei migliori scrittori di fantascienza (la definizione, come abbiamo visto, è labile), Storia vera non contiene nessuna delle caratteristiche citate: legame scienza-fantasia, critica sociale, “dislocazione” (forse).
Questi classici immortali vengono accostati probabilmente per nobilitare la fantascienza. Pratica inutile. Sebbene sia rimasto un alone da letteratura di seconda fascia, possiamo avvicinare a queste narrazioni opere recenti, anch’esse destinate all’eternità.
Questa, in effetti, è l’essenza della fantascienza: la dislocazione concettuale all’interno della società, concepita in maniera tale da generare come risultato una nuova realtà nella mente dell’autore, una realtà che viene poi trasferita sulla carta e dalla carta si manifesta come uno shock nella mente del lettore.
Philip Dick, «Dimensione cosmica», lettera a Sebastiano Fusco
Alberto Palmieri
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!