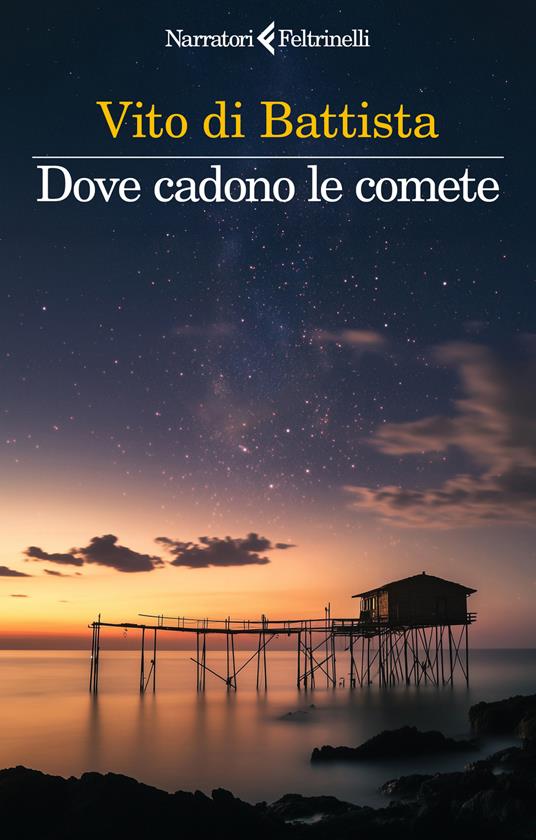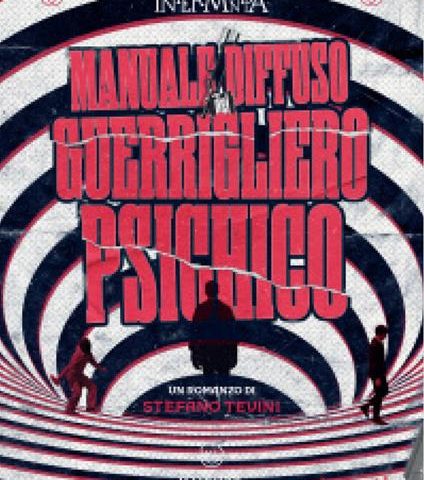«Don’t you forget there’s an anchor around/Called with the name of the boy I once was/May you recall that no matter what we’ll survive». Questi versi sono tratti da A Song My Father Taught Me di ericthegoodsailor, una canzone che è una dedica a chi non c’è più i cui ricordi, rappresentati dal “nome del ragazzo che ero un tempo”, sono un’ancora di salvezza di fronte allo scorrere del tempo e all’oblio.
Raccontare storie e ricordarle è di base un atto che ci permette di vivere e sopravvivere alla morte e allo scorrere del tempo: ci aiuta in sostanza a non morire due volte e ci ricorda come chi è venuto prima di noi, nel bene e nel male, ci abbia permesso di essere quello che siamo oggi. ericthegoodsailor è Vito di Battista, scrittore che ha realizzato questo progetto musicale che consta di un EP – che al momento consta di tre singoli ascoltabili su Spotify e YouTube – dedicato al suo nuovo romanzo Dove cadono le comete, edito da Feltrinelli.
La trama di «Dove cadono le comete»
Ambientato in un paese abruzzesse sulla Costa dei Trabocchi nei pressi della Linea Gustav, la storia di Dove cadono le comete si apre nel 1938 e continua fino agli anni Settanta. Protagonista è Olimpo Liberato, un uomo che già da bambino aveva una certa propensione per le poesie e che, proprio grazie a ciò, invece di fare il calzolaio come il padre riesce a lavorare come impiegato alle poste. Lì conosce Anita, una ragazza che ha subito un incidente che le è costato il braccio sinistro e di cui Olimpo si innamora avendo con lei due figli, Giuseppe e Bianca.
Leggi anche:
Con gli occhi di una bambina
Poiché Anita non ha latte per allattare la figlia, Olimpo si rivolge a Emma, una ragazza “due volte svergognata”, ovvero ripudiata due volte dalla famiglia – sia per una figlia nata morta e avuta da un pastore che l’ha abbandonata, sia per un figlio poi sopravvissuto, ma affidato al convento, e nato, si scoprirà, da un’altra relazione clandestina – che non solo diventerà una seconda mamma per Bianca e governante della famiglia di Olimpo, ma diventerà anche una specie di figlia adottiva per il protagonista, che ha a cuore la sua storia.
La storia dei protagonisti si muove fra i pettegolezzi del paese e l’incedere della Storia, soprattutto l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale, che sembra spazzare via per sempre le vite di tutti, finché un giorno Olimpo decide, sapendo potrebbe perdere la vita durante la guerra, di scrivere delle lettere da lasciare a Emma e ai figli, delle lettere che in realtà nascondono delle storie il cui scopo è quello di mantenere in vita tante piccole storie e il paese che le ha forgiate.
Un buon uso della distanza in una storia famigliare
Chi conosce di Battista sa che è anche autore di Il buon uso della distanza (Gallucci, 2023), un romanzo in parte ispirato alla vicenda di Romain Gary/Émile Ajar che riflette molto sul rapporto fra realtà e finzione attraverso la storia di uno scrittore che pubblica vari romanzi sotto diversi pseudonimi. Questa espressione viene usata anche all’interno di questo nuovo romanzo, che molto riflette sul tema della scrittura grazie alla figura di Olimpo:
Olimpo sta allo studiolo nelle lamie. Batte a macchina quello che è successo ieri, non le storielle che tanto ormai non tengono importanza, ma il resto che attraversa il paese. Per un attimo pensa di starsi giocando l’eternità con queste carte che si ammucchiano e aspettano solo la polvere nel cantuccio dove tanto accorto le ripone, chissà se poi qualche mano sconosciuta un giorno le piglierà, farà un buon uso di quella distanza, capirà il senso che tiene la tragedia quotidiana del suo spigolo di terra.
Questo buon uso della distanza è ribadito anche all’inizio del libro nella nota che scrive l’autore quando afferma che il suo romanzo «è soltanto da parti della verità che ha inizio, poi cerca la sua strada». È così che assumono significato, ad esempio, le fotografie che di Battista mette come sfondo della già citata canzone di ericthegoodsailor nel video pubblicato su YouTube, fotografie che appartengono veramente alla sua famiglia e che intessono con il romanzo un gioco intermediale che dà più forza espressiva al romanzo.
L’autore infatti ha scritto una storia che parte dai fantasmi delle foto e delle memorie che gli appartengono e che sono state innestate nella finzione letteraria, che rimaneggia i ricordi per farli rivivere e dar loro nuova linfa vitale, e allo stesso tempo per provare a stabilire verità in un certo senso negate dai pettegolezzi di paese e dallo scorrere del tempo. È, dunque, questa distanza dalla vita vera creata dalla finzione letteraria che permette a di Battista di scrivere una storia che altrimenti resterebbe sepolta se non addirittura dimenticata per sempre.
L’oralità e la vita di paese in «Dove cadono le comete»
L’originalità in questo romanzo sta anche nello stile che l’autore usa. Di Battista usa infatti un modo di raccontare che deriva dall’oralità, fatto di commenti e riflessioni fatte dal narratore che ci invita, ad esempio, a mettere da parte certi eventi che torneranno utili nei passi successivi della storia, di espressioni come “così è” e di parole che si ripetono come “Come era era”. Questa singolare voce narrativa ha, in realtà, una doppia faccia: da un lato rispecchia la voce del paese e dei suoi pettegolezzi, e dall’altro la voce della memoria e della finzione che vogliono dare a ciò che si racconta la sua verità immacolata dalle voci di paese che non sempre sono veritiere e che agiscono sulla base del sentito dire.
Leggi anche:
Il coro degli ultimi, l’epica dimenticata dei tombaroli
Il paese che ci racconta di Battista in questo romanzo è una realtà piccola, ma universale, non soltanto perché attraversata dai grandi avvenimenti storici, ma anche perché vivi e morti, gente che va e che torna, passato e presente si incontrano in un luogo che racchiude il mondo intero:
Un paese di maschi e femmine che di notte si fanno lupi mannari e gatte infuriate, secche e nere come canne arrostite. Di teste abbellite che paiono caffettiere e sibilano verso la messa dei signori, alle undici di mattina – un paese dove niente si fa da soli e anche le paranze pigliano la via solo se accoppiate, dove trovi sempre qualcuno da qualche parte, dove ci sta il mondo intero pure se il mondo intero questo paese mai lo potrebbe capire.
In un paese con «così tanta gente stipata in così poco spazio» e dove tutti campano di «povertà comune» si nascondono nomi e facce che si fanno «una storia sola»: la storia di una comunità si fa difatti insieme. Il destino di uno è legato a quello degli altri, e tutto ciò dà la sua identità alla comunità stessa, che con l’arrivo della guerra cambia presto volto e rischia di scomparire.
Quello che è scritto non muore
Qui, allora, entra in gioco il tema dell’immaginazione e della scrittura. A Olimpo, infatti, spetta il compito di farsi carico di scrivere i racconti di ciò che accade in paese durante la guerra, sia con le sue cronache giornalistiche che nei suoi taccuini, ma soprattutto a lui spetta il compito di raccontare storie alla figlia Bianca – il cui rapporto ispira la già citata canzone di ericthegoodsailor –, in quanto «quello che è scritto non muore, ninnì, e chi lo scrive neppure».
Se Olimpo scrive, a cantare e a narrare resterà chi verrà dopo di lui. Quella che ha creato con le sue lettere e i suoi racconti altro non è che «l’illusione sciocca che avrebbe potuto riportare tutto a sé una volta che il tutto era scomparso agli occhi di ogni anima». Questo è ciò che resta quando una guerra si porta via tutto: la creazione di un’illusione che ci aiuta a riportare in vita tutto, a farci ricordare che una vita c’è sempre stata e continuerà ad esserci.
La speranza di questa illusione di una nuova promessa spetta a Bianca, in particolare ai suoi figli, che crescono nell’attesa di tutte quelle comete che «arrivano e spariscono e poi tornano quando uno meno se lo aspetta, e nel farlo pigliano tutto e lo rendono un’altra storia ancora». Ciò che aspettano è la promessa di una vita che possa finalmente fare pace con gli errori altrui, con il male commesso da altri, che possa finalmente perdonare e andare avanti sapendo che, nonostante tutto, la vita ha saputo regalare momenti di segreta felicità, una felicità che nessun altro a parte noi conosce.
Nessuno dimentica per davvero, ma nessuno per davvero mai torna indietro
Con un buon uso della distanza – ci scuserà l’autore per il gioco di parole –, Vito di Battista ci consegna con Dove cadono le comete (acquista) un romanzo che non soltanto racconta in maniera struggente ed emozionante le vicende di una famiglia che si intreccia con i grandi avvenimenti storici, ma ragiona anche sull’importanza di raccontare e ricordare le vite che sono state e che, grazie alla memoria, continueranno ancora a essere come monito per sopravvivere alle asperità e per imparare a perdonare un male e un peccato che in fondo sono parte della nostra essenza e che comunque vada ci permettono alla fine di vedere la luce e il futuro.
Non era una lettera, ma la favoletta di un contadino che si tiene la figlia propria pure se il signorotto del paese la vuole allevare come erede e signorinella. Un signorotto e la sua villa sul mare, un giardino di aranci e pini, persino una torretta. Un contadino che confonde orgoglio e affetto, e che in segno di ossequio promette comunque che chiamerà la figlia tenuta con lo stesso nome della moglie del signorotto. Passa qualche anno, però, e il contadino si pente. La figlia merita una vita senza guerra, senza malattia. Una famiglia tutta intera. La consegna al signorotto e si fa da parte. Mai più una parola ci scambia con la figlia donata, però sempre continua a guardarla da lontano. Sempre le canta una canzone. A questa maniera, capisce il contadino, può tenersi davvero a cura quella figlia. Come una cometa quando passa, e sparisce, e chissà se e quando ritorna.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!