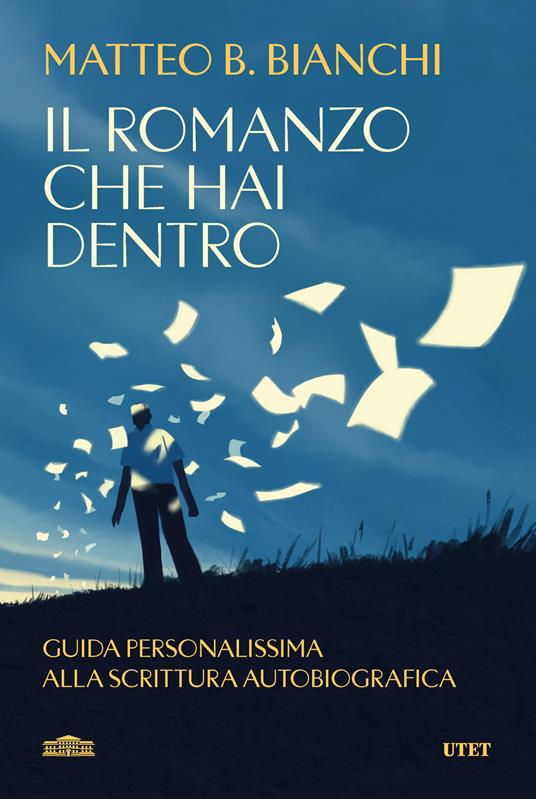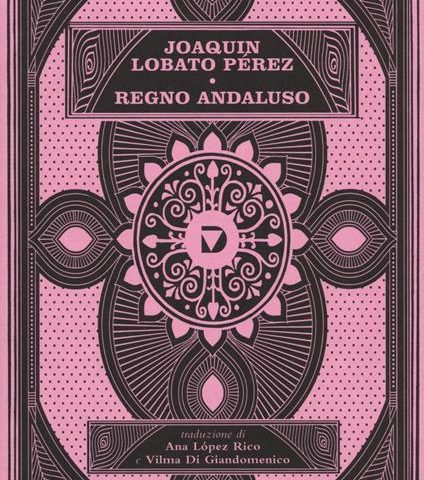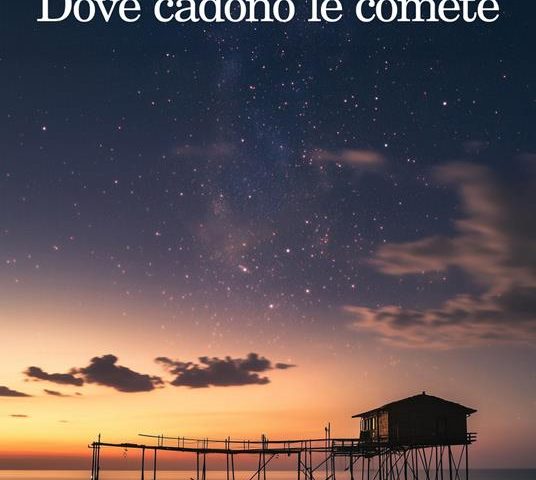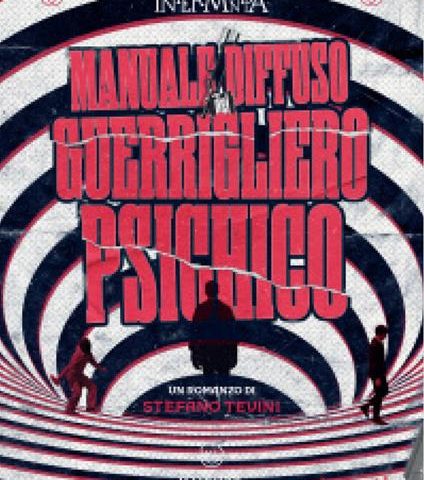Nel suo ultimo libro Corteo, l’autrice americana Rachel Cusk narra di G., un pittore che realizza dipinti con i soggetti capovolti, un modo per uccidere parte di sé e del suo vissuto per fare arte. Così «maturò l’idea d’inversione come strumento per risolvere tale violenza e restaurare il principio d’interezza, così che il mondo fosse di nuovo intatto ma capovolto, e perciò libero dalle costrizioni della realtà». Sacrificando parte di sé e dandola in pasto alla finzione pittorica, il protagonista riesce a dare all’occhio esterno la sua verità, quella che vuole che sia accettata da tutti.
Rachel Cusk in questo modo spiega il suo modo di fare fiction: sacrificare parte di sé e trasformare quel frammento in una realtà universalmente accettata. Dopotutto, in Il realismo è l’impossibile, Walter Siti parla di come la realtà non sia altro che una soglia creata dall’illusione della finzione che attraversiamo pensando sia autentico. Come si realizza ciò prova a spiegarlo Matteo B. Bianchi in Il romanzo che hai dentro. Guida personalissima alla scrittura autobiografica, edito Utet.
Il contenuto in breve di «Il romanzo che hai dentro»
Il romanzo che hai dentro è un saggio che giunge ai lettori dopo l’esperienza struggente dell’autore nella realizzazione del suo ultimo romanzo La vita di chi resta. Proprio in occasione di una presentazione di quest’ultimo a Salerno l’autore, dopo esser stato avvicinato da dei lettori che lo hanno ringraziato per aver fatto luce sul tema della salute mentale, ha capito quanto siano salvifiche le storie che partono dalla nostra vita:
Al di là dei risultati, lo stesso atto della scrittura ha una sua potente validità intrinseca. Più in generale, potremmo dire che scrivere di sé significa davvero “salvare delle vite” perché si stanno salvando quelle vite dall’oblio: ogni testimonianza scritta, ogni rievocazione, ogni memoriale ci lascia tracce di esistenze che altrimenti andrebbero perdute.
Scomodando sia qualche classico che «libri recenti e recentissimi», Matteo B. Bianchi ci offre in questo saggio un’interessante guida su come trasformare la propria vita in un’opera letteraria parlando soprattutto della propria esperienza personale, in quanto «i consigli personali di chi è già passato attraverso le tempeste sono molto più efficaci di tante lezioni teoriche sulla navigazione».
Parlare di sé per insegnarci a parlare della propria vita
Fin dall’inizio, Matteo B. Bianchi ci dice che in questo libro non intende darci un manuale standard di scrittura creativa. Sebbene infatti l’autore nel corso del libro parli della sua esperienza come insegnante di scrittura creativa, trattandosi di un saggio sull’autobiografia decide di mettere da parte la postura e i modi dell’insegnante per parlarci di come raccontare della propria vita:
Se dunque questo non assomiglierà a un manuale standard è perché ho scelto di scriverlo nel modo più personale possibile. Del resto, mi sono detto, non esiste miglior giustificazione letteraria del parlare di sé che una guida sull’autobiografia, no?
Il tono dell’autore, come recita il “best friends” che chiosa il secondo capitolo del saggio – il cui titolo Piacere, mi presento, già dà un’idea dell’impostazione che vuole dare al libro – oppure il “prefe” che troviamo alla fine del libro, è un tono intimo, amichevole, che non vuole parlare ai lettori da nessuna posizione privilegiata, ma vuole parlare loro come un vero e proprio amico che attraverso la propria esperienza vuole guidarli nel trovare il modo migliore di dare voce al proprio vissuto.
Premesse a una scrittura del sé
Dopo un prologo e un capitolo introduttivo, Matteo B. Bianchi prova a differenziare i concetti di autobiografia, romanzo autobiografico e autofiction. Se nel primo caso abbiamo una cronaca quasi giornalistica e dunque fedele della propria vita e nel secondo invece un racconto narrativo di parte delle proprie esperienze vissuto, il terzo termine – quello, passateci il termine, ultimamente più abusato dalla cronaca e dall’editoria per pubblicizzare narrazioni meramente autobiografiche che ormai vanno di moda nel mercato editoriale nostrano – non è altro che «uno strumento per espandere i limiti della narrativa autobiografica, per aggiungere nuovi livelli di lettura, per sperimentare».
Leggi anche:
Annie Ernaux, l’arte della scrittura al Salone di Torino
In ogni caso, come nei già citati esempi di Cusk e Siti, parlare di sé significa far sì che i lettori si affaccino alle nostre vite, di cui in realtà non osservano altro che una loro parte che grazie agli strumenti della finzione diventa un tutto. Siccome, dunque, sempre della propria vita si parla, l’autore fornisce nel saggio degli esercizi e delle indicazioni per far sì di riuscire a parlare della propria vita di modo, alla fine, da non incorrere in conseguenze importanti che possano metterci in difficoltà all’infuori della scrittura.
Ricordi, liste, diari e testimonianze: la scrittura autobiografica
Matteo B. Bianchi inizia la propria dissertazione partendo, dunque, dall’autobiografia, e lo fa tirando in ballo i ricordi di Mi ricordo di Joe Brainard, le liste di Umberto Eco e Lisa Nola, i diari del Piccolo Museo del Diario di Pieve Santo Stefano dove si trova il dattiloscritto di Terra matta di Vincenzo Rabito. Sebbene fare un elenco di ricordi e di eventi della propria vita sia difatti un modo per raccontarla, farlo deve avere secondo l’autore un senso:
Parlare di sé in forma narrativa non è sempre semplice, proprio perché ci si espone in prima persona. E non basta allineare in fila i propri ricordi, bisogna dare loro anche un senso che sia coerente e significativo anche per chi legge. Soprattutto, ci mette di continuo in discussione. Scrivere di sé è come puntare un microscopio verso il proprio passato e vivisezionarlo. Un’operazione interessante, ma tutt’altro che innocua. È bene saperlo e farci i conti da subito.
Già qui l’autore esprime la problematica dell’autobiografia: non solo deve avere un senso farla, ma espone troppo il proprio autore. Scrivere una testimonianza della propria vita ci espone all’occhio esterno dei lettori per provare a guidare le loro vite. Citando Annie Ernaux, Matteo B. Bianchi scrive che il racconto autobiografico ha una valenza tanto personale quanto politica «perché può indurre mutazioni nella vita del lettore, e di conseguenza, nella società», e pertanto siamo responsabili di quanto raccontiamo in quanto attraverso la narrazione possiamo guidare l’agire dei nostri lettori.
Il processo narrativo per rappresentare anche le vite degli altri
Così allora introduce Matteo B. Bianchi il tema del romanzo autobiografico: scrivere di sé spesso ci porta a ingannare gli altri proprio per influenzare le loro vite. Se la scrittura dopotutto è un atto politico, come la politica anche la narrativa indirizza gli altri facendo promesse di verità che in realtà non sono altro che frammenti di realtà confezionati in carta da regalo fatta di illusioni. È così che, ad esempio, nasce il suo romanzo più famoso Generations of Love, dove l’autore «ha scelto di scrivere la sua storia, priva di drammi e di eccessi, praticamente banale, perché immaginava ne potesse rappresentare tante altre».
Leggi anche:
Ombre immaginarie di una paura costante
Con Generations of Love Matteo B. Bianchi ha reso narrativa la propria vita individuando un arco di sviluppo, creando personaggi credibili da persone reali e lavorando sul linguaggio e lo stile. La storia che scriviamo secondo lo scrittore è «elaborata attraverso la nostra sensibilità, le emozioni legate a quel periodo e la vividezza dei ricordi che siamo riusciti a conservare». Sempre l’autore afferma che «quando scriviamo una storia non importa quale sia la verità: conta solo la nostra verità, quella che scegliamo di raccontare e come scegliamo di farlo».
Qui, allora, si presenta un altro problema della scrittura autobiografica che ci porta all’autofiction: scrivere di sé è scrivere di, come direbbe Paul Ricoeur, di un sé come un altro: decido sì di parlare di me, ma di renderlo qualcuno di diverso da me. Questo ci aiuta a parlare delle nostre esperienze trasponendo le vite degli altri e la nostra modificando ogni possibile particolare che si allontana sì da noi, ma che comunque non impediscono al racconto di essere autentico.
Dall’autobiografia all’autofiction, o “altrabiografia”
Citando Dorothy Allison, autrice di La bastarda della Carolina, Matteo B. Bianchi afferma che la fiction permette di raggiungere una verità più ampia di quello che il mero racconto autobiografico ci permette, perché nel momento in cui rendo fittizia la mia vita trasformando i suoi dettagli riesco liberamente a dire quello che non potrei dire in una cronaca fedele e cronologica dei fatti.
Qui l’autore cita colei che in Italia è la maestra dell’autofiction, Teresa Ciabatti, che a proposito di La più amata parla di autobiografia menzognera, uno spazio idealizzato simile al “non-spazio” teorizzato da Rachel Cusk che «prende il posto della certezza del passato» per dare una propria versione del proprio vissuto:
“Ciascuno di noi sopravvive su ricordi fasulli. Siamo un’invenzione di noi stessi. L’autofiction è perciò il racconto della proiezione di sé, il sé più falso, quasi sempre idealizzato. In genere chi si racconta si fa più intelligente, acuto, brillante, conquistatore, onesto.
Alla fine, che si scriva in maniera fittizia o veritiera su di noi, sempre di un’invenzione si parla, in quanto ogni scrittore che decide di parlare di sé e della propria esperienza di vita è chiamato a operare delle scelte, a capovolgere la propria vita per proteggersi in un certo senso e non esporsi troppo, e dunque la vita di cui si finisce di parlare è una vita inventata, ma grazie all’intelligenza dell’autore presentata come vera.
Essere pronti a difendere la propria vita e la propria verità
Per spiegare meglio il prodotto finale che dovrebbe emergere dopo aver letto Il romanzo che hai dentro, useremmo un termine tanto caro al Premio Nobel J.M. Coetzee, ovvero autrebiography, vale a dire un racconto di sé volutamente falsato per non esporsi troppo in prima persona né a livello di esposizione mediatica né a livello emotivo, un racconto di sé che si muove in bilico fra realtà e finzione che gioca con la percezione dei lettori.
Nel momento in cui, dunque, decidiamo di scrivere di noi, per forza di cose stiamo scrivendo di un noi stessi proiettato all’infuori dai nostri confini fisici che abbiamo deciso essere il nostro vero io, e quando decidiamo di pubblicare un racconto su di noi, dobbiamo sempre essere pronti a difendere una verità che abbiamo scelto essere tale, e l’unico modo per farlo è operare una netta separazione fra il noi stessi fisico e il noi stessi fittizio.
Parlare di vite il cui finale lo decidiamo noi
Se da un lato – si chiede scusa per l’anticipazione, anche se gli spoiler in saggistica non esistono – Il romanzo che hai dentro (acquista) finisce con dei consigli su come affrontare il momento della ricerca dell’editore e della pubblicazione del libro, dall’altro finisce anche con la seguente consapevolezza: nella scrittura autobiografica il finale della propria vita lo scegliamo noi. Citando Antonio Franchini, Matteo B. Bianchi sostiene che in fondo non siamo altri che dittatori della propria vita nel momento in cui scegliamo cosa includere e cosa no nel nostro racconto autobiografico, ma che sia memoir, autobiografia o autofiction, il racconto autobiografico ci permette di essere padroni della propria vita, di rimediare agli sbagli passati e attraverso la scrittura indirizzare la nostra vita verso un finale migliore.
A volte ho l’impressione che tutto il dolore che ho dovuto attraversare sia stato parte integrante del percorso che mi ha portato a essere questo scrittore, che i vent’anni di ripensamenti e di dilazioni non siano stati una forma ostinata di procrastinazione ma una silente e inesorabile stesura interiore del testo. E che attraverso la parole scritte, nel produrre l’oggetto finale libro, tutto questo abbia acquisito, finalmente, un senso.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!