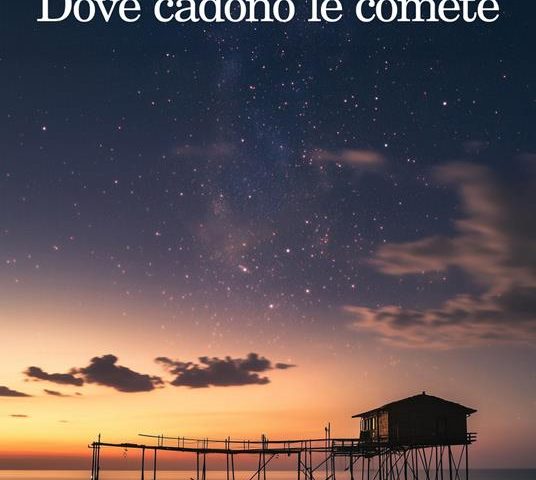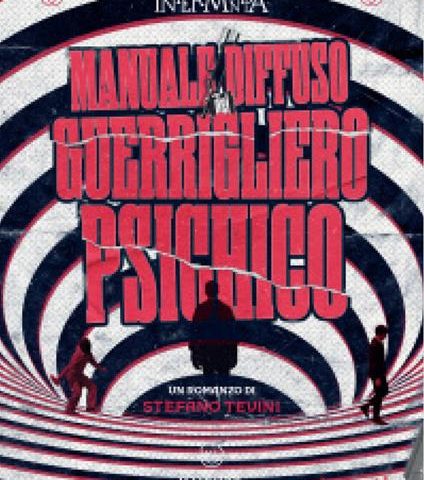Di cosa si parla quando si parla di cold case? Molti di voi che leggeranno questo pezzo staranno pensando all’omonima serie tv. Certo, ma non solo: cold case si usa in gergo per indicare un caso irrisolto senza trovare un colpevole. Fra questi nel belpaese abbiamo il caso di Wilma Montesi, accaduto sulla spiaggia di Torvaianica, oppure quello di Simonetta Cesaroni in via Poma a Roma. Questi casi continuano ancora a tenere alta l’attenzione dei cittadini italiani, soprattutto grazie alla realizzazione di podcast di true crime, narrazioni di delitti realmente accaduti usando gli strumenti della narrativa e diffuse attraverso vari media.
Anche la letteratura italiana si sta cimentando in questo genere, come ad esempio Silvia Cassioli che arrivò in finale al Premio Bergamo di qualche anno fa con Il capro, dedicato al Mostro di Firenze, e con Wilma, dedicato al caso Montesi, ma anche Alessandro Ceccherini con Il mostro e Che venga la notte, e soprattutto la coppia di autori noir Antonio Paolacci e Paola Ronco che per la giovane casa editrice Ubagu Press hanno recentemente pubblicato Rosso profondo, secondo titolo in assoluto della neonata casa editrice.
La trama di «Rosso profondo»
Torino, settembre 1991. Luigi Jourdan, senzatetto di cinquantasette anni detto anche Luciano o Ciano da anni stanziatosi in Frazione Barauda, trova sotto il ponte che passa sopra la tangenziale sud fra La Loggia e Moncalieri il corpo di una donna avvolto da un vestito rosso inizialmente assomigliante a un manichino e abbandonato per terra come del resto sono tutti gli oggetti lasciati sotto ai cavalcavia:
È lì, come un oggetto rotto; confuso con il resto e quasi invisibile, uno scarto tra gli scarti. Perché un corpo umano non è diverso da ogni altra cosa; non fa nulla per farsi riconoscere. Bisogna avvicinarsi per vederlo davvero.
La donna in questione è Franca Demichela, torinese di quarantotto anni figlia di un vecchio dirigente Fiat e sposata con Giorgio Capra, ragioniere anche lui impiegato alla Fiat. I due sono persone molto diverse fra loro, non soltanto per la grande differenza di età, ma anche perché Demichela era molto amante della bella vita al punto da voler frequentare gente più giovane di lei con il tacito consenso – probabilmente, ma su questo il mistero resta irrisolto – del marito.
Leggi anche:
Un’insanguinata dedica d’amore a Los Angeles
Trentatrè anni dopo, due scrittori, Antonio Paolacci e Paola Ronco, che qui parlano di sé in terza persona per meglio raccontare dal punto di vista linguistico le scene in cui appaiono come protagonisti, decidono di dedicare la loro ultima fatica a questo cold case, scoprendo che il delitto Demichela è molto di più di un cold case. È la storia di un paese che affronta le prime migrazioni dai paesi est europei, che si confronta con il maxi-processo di Cosa nostra, e che attraverso la lente di una Torino esoterica e caotica mostra i segni della crisi dell’industria metallurgica e del vecchio sistema economico, politico e sociale su cui si reggeva il paese fino a quel momento.
«Rosso profondo»: fare true crime e cronaca d’Italia
Quanto detto prima non è un caso: se leggiamo gli eserghi tratti da Gadda e la coppia Fruttero e Lucentini, lo scopo di Paolacci e Ronco è evidente: l’uso del true crime serve da un lato a mostrare “lo gnommero” di un paese che ai tempi stava attraversando grandi cambiamenti sociali ed economici e dall’altro una critica al modo in cui all’epoca si raccontavano i fatti con superficialità da un lato e alla mancanza di profondità della vita moderna dall’altro.
Leggendo la nuova fatica di Paolacci e Ronco tornano in mente le seguenti parole di Giancarlo De Cataldo in Per questi motivi, scritte tenendo a mente Roma in cronaca nera di Enzo Rava, a cui l’autore di Romanzo criminale deve molto:
È l’idea che la “nera” non sia solo morbosità, ma specchio del Paese. Che in ognuno dei delitti che tengono desta per mese, se non per anni, la nostra attenzione, proprio in quel “tener desta” c’è qualcosa che va oltre il whodunit, la dinamica del singolo caso, la scoperta del colpevole. Qualcosa di più profondo che sta proprio nel fatto che un delitto – e non un altro –, quel delitto – e non quell’altro – ci strega e ci turba. Qualcosa che ha a che vedere con lo Zeitgeist, lo spirito dei tempi.
Paolacci e Ronco come scrittori fanno tesoro delle parole di De Cataldo unendo la morbosità degli italiani e dei giornalisti allo spirito del tempo, a ciò che ha reso il nostro paese quello che poi è diventato oggi. Il caso Demichela, dunque, diventa cartina di tornasole per leggere e conoscere il belpaese e capire i suoi mutamenti, che ancora oggi sono evidenti e influenzano tuttora l’opinione pubblica e il nostro tessuto sociale.
L’Italia e Torino attraverso la dama in rosso
Conoscere il caso della dama in rosso significa in primo luogo conoscere bene il contesto in cui è avvenuto. Stiamo parlando della Torino di fine anni Ottanta e inizi anni Novanta, una città rappresentativa del nostro paese perché sede della più grande industria metallurgica del paese – la Fiat – e dunque perfetta cartina per orientarsi nei mutamenti dell’Italia.
L’Italia che ci raccontano Paolacci e Ronco attraverso il caso Demichela è un paese in cui, ad esempio, la stampa e l’intrattenimento usano un linguaggio che mostra poca predisposizione ad andare in profondità nelle cose, in cui «una donna probabile vittima di tratta» è considerata «”una professionista dell’amore”» e che «prestano attenzione a pericoli che si nascondono non più ai vertici del potere, ma per le strade e nelle case» interpretando certi delitti attraverso le lenti della cinematografia e della televisione facendo così di tutta l’erba un fascio: è il periodo, infatti, di Twin Peaks e Il silenzio degli innocenti.
Leggi anche:
Fame d’amore
Questi sono gli anni in cui, a Torino come in tante altre città, si vivono le prime migrazioni da altri paesi, con l’opinione pubblica che bolla chi viene dall’Europa dell’est come zingaro e avvezzo al crimine, e non bisogna stupirsi se chi li frequenta ne diventa vittima. Oltre a questo, Torino è anche la città dell’esoterismo e della magia nera, e sapendo che Demichela frequentava anche questi ambienti, c’è chi pensava addirittura a certi giri di denaro e sfruttamento dove la donna poteva esercitare la propria influenza per vendere, ad esempio, gioielli rubati sfruttando la propensione al crimine degli stranieri.
Rovesciamento di un paradigma
Paolacci e Ronco notano, però, che il caso Demichela «restituisce l’idea di anni cruciali per il paese; anni in cui tutto è cambiato, non solo il linguaggio, ma anche il modo di fare politica, e quello di raccontare il crimine». Qui, dunque, abbiamo l’influenza di Fruttero e Lucentini nel momento in cui si cerca di smontare il modo di fare giornalismo, dove Demichela veniva associata all’immagine della moglie fedele, della lolita o della misteriosa donna in rosso dell’omonimo film di Gene Wilder senza, però, porre l’accento sulla sua voglia e il suo diritto alla libertà.
Il caso Demichela, inoltre, secondo gli autori ha influenzato molto il modo di scrivere narrativa poliziesca, in quanto, se da un lato si considera ancora la narrativa crime superficiale, commerciale e tendente al sensazionale, dall’altro, in realtà, gli scrittori di crime tematizzano la difficoltà di dare una verità unica per tutti sui casi presi in esame: i vuoti di memoria, la manipolazione dei ricordi, ma anche gli strumenti scientifici con cui prima e dopo si conducevano le indagini contribuiscono soltanto a rendere più opaca la ricerca della verità.
Cosa resta da fare, allora, a uno scrittore di crime, o meglio true crime? Semplicemente quello di raccogliere più testimonianze possibili e raccontarle maturando la giusta neutralità e considerandole frutto di un errore umano che ricorda ciò che riesce, che mette assieme i pezzi senza l’intenzione di mentire, e attraverso ciò dare un ritratto fedele di ciò che è potuto accadere.
È stata l’Italia a uccidere Franca Demichela?
Se, dunque, a seguito delle indagini sono stati scagionati Giorgio Capra e gli immigrati est europei frequentati da Demichela come Stanko Stojanovic, allora non ci resta che affermare che l’unica responsabile di questo cold case è stata l’Italia. Il caso Demichela si fa, così, delitto in cui la colpa è collettiva: è stata l’Italia, un paese che ad esempio non accettava ancora del tutto l’idea che una donna potesse essere indipendente e che un uomo che lavorava alla Fiat – azienda sinonimo di famiglia e rispettabilità borghese – potesse essere considerato responsabile di un delitto così efferato:
La Fiat nel 1991 è la massima rappresentante storica di un’epoca che sembra infinita, un tempo in cui la stessa idea di lavoro viene confusa ad arte, nel lessico lavorativo stesso, con quella di famiglia.
Oltre a questo, l’Italia è un paese che da una parte mantiene una parvenza di perbenismo, ma dall’altra nasconde il torbido. L’Italia è un paese che lancia invettive contro “i nuovi barbari”, ma poi certi elementi della società delinquono assieme ai “delinquenti zingari”. In questo senso è da interpretare quanto dicono gli autori, secondo i quali chi è riuscito meglio a rappresentare Torino – è dunque l’Italia – è stato Dario Argento, che «ha mostrato il Male come qualcosa di diffuso nel contesto, potente e sfuggente quanto una stregoneria». Il Male, come le persone, è enigmatico: tutti sono coinvolti, nessuno escluso, e per andare avanti ha bisogno di delitti come quello di Demichela per continuare a esistere con il tacito consenso delle istituzioni.
Ogni storia vera è una storia priva di finale
Ogni storia vera è una storia priva di finale: così si può riassumere la storia di Franca Demichela e così si potrebbe riassumere Rosso profondo (acquista). Attraverso la storia della dama in rosso, Paolacci e Ronco non solo hanno cercato di dare dignità alla storia di una donna privata della propria persona da parte di una società che non accettava di lasciarla vivere libera, ma hanno anche sovvertito la scrittura del romanzo giallo e la narrazione del crimine in Italia.
Raccontare un crimine significa non soltanto raccontare la vittima e i probabili colpevoli, ma anche raccontare un contesto, unico responsabile di una storia che alla fine lascia molti enigmi irrisolti. Riprendendo le parole di De Cataldo, la storia di Demichela è prima di tutto la storia di un paese, l’Italia, che con questo crimine ha dimostrato di non accettare l’emancipazione femminile ma anche di non accettare l’evoluzione sociale ed economica che stava attraversando, mostrandosi come oggi un paese che difficilmente accetta il progresso.
Il mistero sono gli amici di Franca, le sue conoscenze; i vicini di casa, suo marito, il clochard che ne ha trovato il corpo, la prostituta che abitava nel suo quartiere, i nomadi e le loro famiglie, i baristi che la sbattono fuori, i giornalisti che semplificano, gli inquirenti con i loro errori e le loro certezze; ogni persona che non ci pensa, che si ritiene in automatico nel giusto, che mente, che ostacola e interpreta i fatti, che tralascia dettagli o ne esalta il peso: ogni persona è un enigma.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!