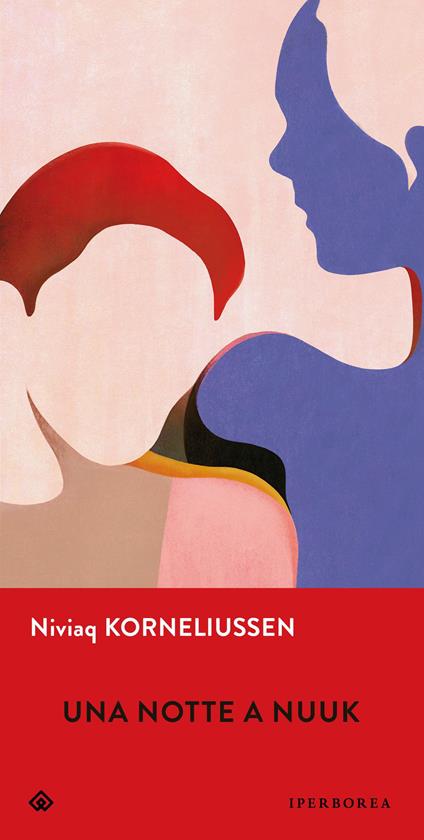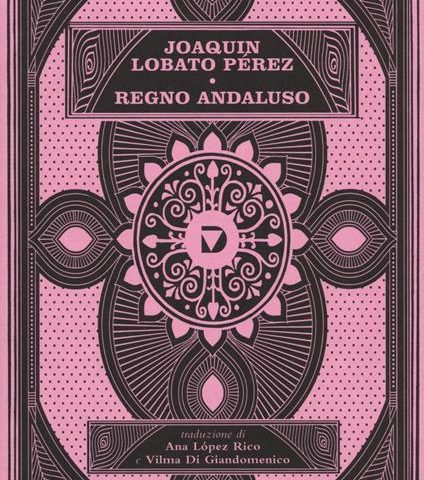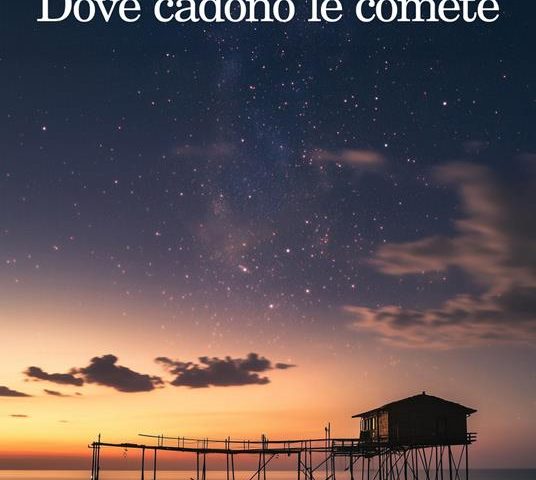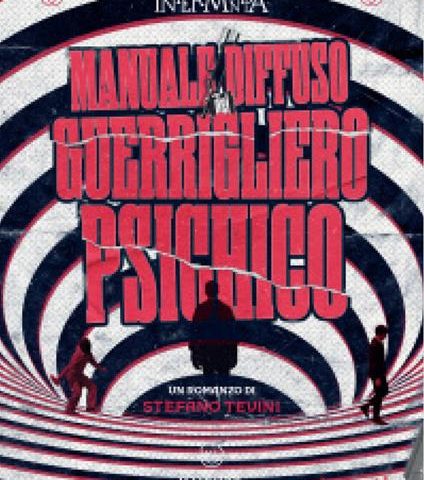Recentemente si è sentito spesso parlare di Groenlandia – dal 1979 sotto Home Rule concessa dalla Danimarca, Paese da cui dipende – per il desiderio dell’attuale Presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annetterla. Questo perché l’isola artica non è nota soltanto per le sue “terre rare”, minerali e risorse fondamentali soprattutto per l’economia digitale e la transizione ecologica, ma anche perché è un avamposto strategico per le rotte artiche, che interessano anche al vero rivale degli Stati Uniti, la Cina.
La Groenlandia è un’isola che da anni lotta per la propria autonomia, ma è un territorio ancora in conflitto con la sua identità per via, fra le tante cose, del colonialismo. Il concetto di identità per i groenlandesi è, dunque, fondamentale, soprattutto perché si sentono isolati dal resto del mondo e dai processi globali più importanti. L’identità dei groenlandesi è un tema molto caro a Niviaq Korneliussen, che dopo La valle dei fiori ritorna nelle librerie italiane con Una notte a Nuuk (Iperborea, 2025), esordio originariamente pubblicato nel 2014.
La trama di «Una notte a Nuuk»
Una notte a Nuuk si svolge nell’arco di una notte raccontata dal punto di vista di cinque protagonisti che sono alla ricerca di una propria identità in un paese come la Groenlandia che non permette loro di essere sé stessi. Fia, ad esempio, non si sente felice con il suo fidanzato Peter e si innamora di Sara, quest’ultima fidanzata con Ivik, a sua volta a disagio col proprio corpo in quanto alla scoperta della propria identità trans.
Leggi anche:
«Le transizioni» di Pajtim Statovci: essere umano, essere mondo
Quanto agli altri due personaggi del romanzo, Arnaq lotta con i propri demoni – problemi con l’alcol e abusi subiti dal padre – che si rispecchiano nei suoi problemi relazionali, mentre Inuk, il fratello di Fia, è omosessuale, ma si sente in trappola nella società groenlandese, che lui vede come una prigione dove tutti lo giudicano dall’alto verso il basso facendolo sentire ancora più un reietto.
In questa notte groenlandese, i cinque protagonisti imparano a confrontarsi con i propri desideri e la propria fisicità, ma allo stesso tempo a seguire la propria strada e sfidare le regole di una società che preclude loro ogni possibilità di esprimere il proprio vero io e di vivere, dunque, la propria sessualità e identità di genere in maniera libera.
Da «HOMO Sapienne» a «Una notte a Nuuk»
Per l’edizione italiana di questo esordio di Niviaq Korneliussen, si è deciso di fare come gli americani, ovvero usare il titolo Una notte a Nuuk: l’edizione americana è infatti intitolata Last Night in Nuuk, a differenza di quella inglese intitolata Crimson, mentre quella tedesca è intitolata Nuuk #ohne Filter, letteralmente “Nuuk #senza filtri”, che con il cancelletto e il richiamo al filtro non soltanto indica l’uso del linguaggio dei social media, ma anche una certa propensione a mostrare l’identità di genere dei protagonisti e il loro orientamento sessuale in tutta la loro verità.
L’edizione originale, però, porta come titolo HOMO sapienne, che comprendiamo essere di difficile comprensione per il lettore italiano medio. Se il titolo italiano e inglese americano relegano la scoperta della sessualità dei protagonisti a una notte, dando l’impressione che tutto inizi e finisca in quel preciso momento, il titolo originale d’altro canto rende questa scoperta qualcosa di duraturo al punto da creare una nuova “specie umana”. HOMO sapienne, infatti, è un gioco di parole fra homo sapiens – con cui si firma Inuk in una delle mail alla sorella Fia –, la parola inglese homosexual e il femminile del termine latino sapiens.
Leggi anche:
Sotto il segno del dolore, in nome del piacere
Il titolo originale, dunque, rende meglio l’idea di una scoperta della propria identità di genere radicale, che non coinvolge soltanto il corpo e il genere sessuale, ma anche la lingua. Korneliussen difatti scardina la lingua creando una commistione di inglese – non sempre grammaticalmente corretto, ma l’effetto è voluto come ribellione alle regole –, groenlandese e danese, ma soprattutto di immagini e canzoni – i titoli dei capitoli sono titoli di alcune canzoni famose come Walk of Shame di P!nk – che creano un nuovo linguaggio per comunicare ciò che la società dei protagonisti rende impossibile persino vivere.
«Enough of that post-colonial piece of shit»
Come con La valle dei fiori, anche per Una notte a Nuuk è necessario parlare del contesto groenlandese. Chi ha già letto il primo sa che per Korneliussen la questione groenlandese è abbastanza complessa, ma ci si arriverà per gradi. Una panoramica sulla Groenlandia ce l’abbiamo grazie alle mail che Inuk invia a sua sorella Fia, dove parla dell’isola artica in termini di prigione e di marginalità:
Sono arrivato in prigione. Le mura, che a guardarle dall’alto sembravano così basse, circondano l’area come montagne altissime. Mi rendo conto che non si può fuggire. Riconosco l’odore di prigione e il sentore di sofferenza. […] Guardo i detenuti con cui devo dividere la cella. Sono così chiusi in se stessi che si fissano l’un l’altro finché non cominciano a perdere la testa e questo mi spaventa. Mi guardano e aspettano. Mi tengono d’occhio, come un branco di beve, pronti a mordermi.
Inuk parla della Groenlandia in termini di “muffa schifosa”, “infezione”, “rancido”, “un’isola circondata dal nulla” e “un’isola prigione” i cui figli sono “marci”. Per il protagonista, essere groenlandese è una vergogna, perché dietro alla volontà di contribuire al benessere economico c’è, secondo lui, una verità di rabbia, bugie, autocommiserazione e soprattutto abusi.
Nemmeno, però, la Danimarca, dove poi scapperà, risulta essere casa sua, ma rispondendo all’autocommiserazione di Arnaq dice una frase fondamentale, che racchiude la posizione di Korneliussen nei confronti del colonialismo: «Enough of that post-colonial piece of shit». La propria identità, dunque, non è da ricercarsi in un’appartenenza nazionale, ma in sé stessi.
La rinascita che passa per il corpo
Non è un caso che Inuk si firmi nella mail finale come Homo sapiens. Se restiamo nel gioco di parole del titolo originale, Inuk – in groenlandese “umano” – stabilisce la sua identità di essere umano in quanto uomo, ma anche in quanto omosessuale. Inuk rinasce alla vita perché ha ascoltato il suo desiderio, ovvero la sua attrazione per persone dello stesso sesso.
La consapevolezza della propria identità sessuale passa, però, attraverso il corpo. Tanti sono i corpi che Korneliussen mette in scena, e la corporeità, se consideriamo le immagini a corredo di ogni capitolo, è fondamentale, perché è nel corpo che si gioca la battaglia più grande, quella per la libertà di esprimere la propria identità. Se da un lato abbiamo, ad esempio, il corpo della nipote di Sara, una neonata indifesa e soggetta alle osservazioni e ai commenti altrui, dall’altro, invece, abbiamo dei corpi irrequieti: quello di Fia, che si sente insoddisfatta dell’amore per Peter, e quelli incontrollabili e ribelli di Arnaq e Sara.
Chi vive, però, un rapporto molto conflittuale con il corpo è Ivik, il cui nome in realtà è Ivinnguaq. Il suo è un corpo pieno di dubbi, che arriva persino ad avere paura del contatto fisico, come dimostrano le scene assieme alla fidanzata Sara:
Guarda il mio corpo nudo e inizia a baciarmi. Io le tolgo i vestiti e la butto sul letto. Spengo i pensieri e cerco di concentrarmi sul mio corpo eccitato, lascio a lui il controllo. Ma quando sono sopra di lei, mi prende per le spalle e mi fa sdraiare di schiena. […] Cerco di resistere ma finisco per scostarmi, nemmeno il mio corpo ce la può fare. Tiro fuori le dita da lei. Prima che la sua mano si possa avvicinare troppo mi ritraggo.
Nel corso della sua relazione con Sara, Ivik sente che la sua anima è malata: non tanto per Sara, ma perché continua ad avere molti dubbi su di sé che si risolveranno nel momento in cui comincia ad ascoltare il suo corpo, che non vuole più essere percepito come femminile, ma maschile. Ed è qui, allora, che rinasce definitivamente come Ivik: nel momento in cui ha iniziato ad ascoltare il desiderio di abitare un corpo maschile e dunque di far emergere la propria identità trans.
L’identità come fatto corporeo
Già più di dieci anni fa, Niviaq Korneliussen aveva dimostrato di essere una scrittrice matura con un esordio che pone l’accento sull’identità di genere uscendo dai confini insulari e rendendola universale. Per i protagonisti di Una notte a Nuuk (acquista), la costruzione della propria identità è dunque un riallineamento di corpo, desideri e soprattutto linguaggio. L’identità di genere non passa solo dal desiderio e dal corpo, ma anche dalla ricerca di un linguaggio che la sappia comunicare. Sono questi elementi che rendono le persone libere di esprimersi, soprattutto in un contesto che li rende doppiamente emarginati.
Vado in bagno per calmarmi. Che succede? Io, la persona più chiacchierona del mondo, sono appena diventata muta? Io, la bugiarda più abile di tutti, non sono nemmeno riuscita a mentire? Non può essere. La sicurezza da cui ho tentato di fuggire per gli ultimi tre anni è appena svanita. Sono tesa. Spaventata. Non mi sento al sicuro. Peter. Vorrei trovare un po’ di pace da Peter. Esco dal bagno e il mio corpo inquieto si dirige di nuovo verso il salone. I can’t stay away.
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!