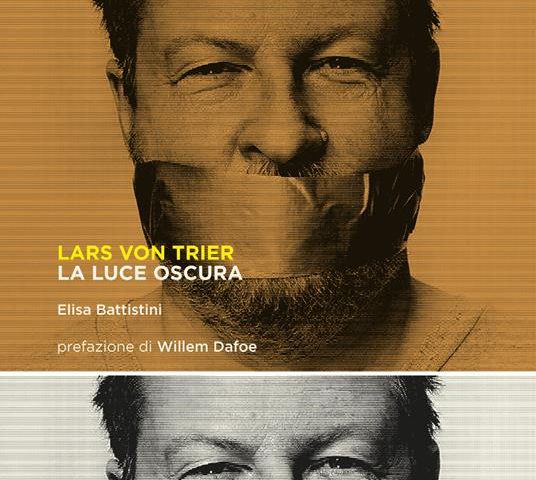In occasione dell’ultimo Festival Letteratura di Mantova nel settembre dell’anno scorso, Georgi Gospodinov, in una Basilica Palatina di Santa Barbara gremita, aveva annunciato l’uscita anche in Italia, sempre per Voland, del suo ultimo volume: Il giardiniere e la morte. Accompagnato da un’eccellente Federica Manzon, il suo intervento verteva su come noi stessi siamo macchine del passato, come vi nasciamo e viviamo. Tuttavia, sul finale della conferenza, la mente è andata su quest’ultimo libro.
In ossequio a una delle sue massime più famose, pronunciate dal suo alter-ego Gaustìn, anche in questo caso «il romanzo non è ariano». Novantuno paragrafi di diversa lunghezza, in cui dalla prosa affiora la poesia, dove Gospodinov affronta la perdita del padre. I fatti concreti diventano storie perché «solo le storie sopravvivono». Non è la prima volta che l’autore affronta questo tema, ma con Il giardiniere e la morte sembrerebbe trovare una sua forma definitiva. Tutto inizia con l’immagine di un giardino…
Giardinaggio e morte
«Mio padre era giardiniere. Ora è giardino»: così è l’incipit dell’ultimo libro di Georgi Gospodinov. E questo incipit viene ripetuto più volte nel corso dei capitoli, come un mantra. Una rielaborazione della perdita, un capolavoro che ha preso forma, a dire dello stesso scrittore, su fogli sparsi, come solo succede con le sue poesie, durante la malattia del padre.
Un rito apotropaico che racconta il sintomo della morte per allontanarla: come se ogni pagina scritta servisse per alimentare la vita del genitore giorno per giorno. Come, d’altronde, accade per la presenza dello stesso giardino:
Giardinaggio e morte. Penso che possiamo riconoscere il giardinaggio come originariamente orientato contro la morte. […] Penso che l’idea della resurrezione sia un’idea botanica. […] Anche l’immortalità è una categoria botanica. Tutte le piante, che noi riteniamo una fase primitiva dell’evoluzione, in realtà conoscono un prodigio in più, possiedono un superpotere in più rispetto a noi. Sanno come morire, in modo da tornare di nuovo in vita.
Infatti Il giardiniere e la morte potrebbe iniziare in diversi modi, perché è impossibile trovare una sorgente al ricordo. Non esiste un percorso univoco. Gospodinov traccia itinerari fra avvii, false partenze, arrivi, ritardi e sentieri. Senza sfociare nell’autobiografismo patetico, Gospodinov dona dignità a suo padre, il suo eroe umano, troppo umano.
Una storia che trova riscontro in riflessioni, aneddoti e momenti condivisi. La vita personale si incrocia con le vicende socio-politiche della Bulgaria, dal crollo del socialismo alla Festa di San Giorgio. Come in Cronorifugio anche qui il tempo è sovrano, ma più rispettoso, quasi silenzioso nel suo scorrere, tanto che in questo romanzo anche l’onnipresente Gaustìn rimane in disparte.
Leggi anche:
«Cronorifugio»: la genealogia del presente
Il senso della possibilità
La morte è crudele, ma per citare L’uomo senza qualità di Musil: «se esiste un senso della realtà, allora ci dev’essere anche il senso della possibilità». Così il padre di Gospodinov trova durante la vecchiaia un rifugio sereno nel proprio giardino. Un orto dove lavora e coltiva, un’arte che mette a disposizione i propri frutti anche per chi verrà dopo.
Un senso di abnegazione e altruismo pervade molte delle pagine de Il giardiniere e la morte. Un senso di praticità tipica che trova una sua manifestazione nella mancanza di lamentele, nell’addomesticare il dolore o, più semplicemente, nel ricordare ai propri famigliari dove si trova la carta d’identità per evitare inutili ricerche. È chiara dunque la volontà di un andarsene silenzioso, senza arrecare danno alcuno, e ricongiungersi alla propria terra che tanto si è accudita:
Così immaginavo, dopo un po’ di tempo, il pezzetto di terra in cui giace mio padre – fiori, piante aromatiche e api ronzanti, che si abbassano in volo verso di lui con le ultime notizie dei campi e dei giardini vicini.
«Il giardiniere e la morte»: il dono di Laerte
La capacità di Gospodinov è di rendere tutti questi eventi pura letteratura. Uno dei punti salienti è la conoscenza e i riferimenti ai classici, primo tra tutti l’Odissea. L’autore ricorda l’incontro fra Ulisse, reduce dal suo lungo viaggio, e il padre Laerte. Anche in questa circostanza affiora il ricordo. Memoria che diventa immagine e quindi testimonianza. Il dono del giardino del padre si fa segno distintivo per il figlio.
Leggi anche:
Come coltivare una rosa bianca
Il dono di Laerte si tramanda di generazione in generazione, e Gospodinov e il padre ne diventano testimoni. Nel Giardiniere e la morte (acquista) si cerca di indagare questo tesoro, di dare forma a questa fisica della malinconia.
Il giardino è il luogo dove si intrecciano tristezza e speranza in un equilibrio dinamico, per citare un’intervista dell’autore riportata su L’Espresso. È vero quando Gospodinov scrive: «La botanica sa come si muore in bellezza, senza morire. La botanica sa ancora molto di più riguardo alla morte».
Non abbiamo grandi editori alle spalle. Gli unici nostri padroni sono i lettori. Sostieni la cultura giovane, libera e indipendente: iscriviti al FR Club!